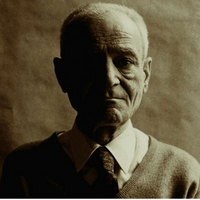Ad portam Inferi
Chi avrebbe mai pensato, allora,
di doverla incontrare
un’alba (così sola
e debole, e senza
l’appoggio di una parola)
seduta in quella stazione,
la mano sul tavolino
freddo, ad aspettare
l’ultima coincidenza
per l’ultima destinazione?
Posato il fagottino
in terra, con una cocca
del fazzoletto (di nebbia
e di vapori è piena
la sala, e vi si sfanno
i treni che vengono e vanno
senza fermarsi) asciuga
di soppiatto – in fretta
come fa la servetta
scacciata, che del servizio
nuovo ignora il padrone
e il vizio – la sola
lacrima che le sgorga
calda, e le brucia la gola.
Davanti al cappuccino
che si raffredda, Annina
di nuovo senza anello, pensa
di scrivere al suo bambino
almeno una cartolina:
“Caro, son qui: ti scrivo
per dirti...” Ma invano tenta
di ricordare: non sa
nemmeno lei, non rammenta
se è morto o se è ancora vivo,
e si confonde (la testa
le gira vuota) e intanto,
mentre le cresce il pianto
in petto, cerca
confusa nella borsetta
la matita, scordata
(s’accorge con una stretta
al cuore) con le chiavi di casa.
Vorrebbe anche al suo marito
scrivere due righe, in fretta.
Dirgli, come faceva
quando in giorni più netti
andava a Colle Salvetti,
“Attilio caro, ho lasciato
il caffè sul gas e il burro
nella credenza: compra
solo un po’ di spaghetti,
e vedi di non lavorare
troppo (non ti stancare
come al solito) e fuma
un poco meno, senza,
ti prego, approfittare
ancora della mia partenza,
chiudendo il contatore,
se esci, anche per poche ore”
Ma poi s’accorge che al dito
non ha più anello, e il cervello
di nuovo le si confonde
smarrito; e mentre
cerca invano di bere
freddo ormai il cappuccino
(la mano le trema: non riesce
con tanta gente che esce
ed entra, ad alzare il bicchiere)
ritorna col suo pensiero
(guardando il cameriere
che intanto sparecchia, serio
lasciando sul tavolino
il resto)
al suo bambino.
Almeno le venisse in mente
che quel bambino è sparito!
E’ cresciuto, ha tradito,
fugge ora rincorso
pel mondo dall’errore
e dal peccato, e morso
dal cane del suo rimorso
inutile, solo
è rimasto a nutrire,
smilzo come un usignolo,
la sua magra famiglia
(il maschio, Rina, la figlia)
con colpe da non finire.
Ma lei, anche se le si strappa
il cuore, come può ricordare,
con tutti quei cacciatori
intorno, tutta quella grappa,
i cani che a muso chino
fiutano il suo fagottino
misero, e poi da un angolo
scodinzolano e la stanno a guardare
con occhi che subito piangono?
Nemmeno sa distinguere bene,
ormai, tra marito e figliolo.
Vorrebbe piangere, cerca
sul marmo il tovagliolo
già tolto, e in terra
(vagamente la guerra
le torna in mente, e fischiare
a lungo nell’alba sente
un treno militare)
guarda fra tanto fumo
e tante bucce d’arancio
(fra tanto odore di rancio
e di pioggia) il solo
ed unico tesoro che ha potuto salvare
e che (lei non può capire)
fra i piedi di tanta gente
i cani stanno ad annusare.
“Signore, cosa devo fare”
quasi vorrebbe urlare,
come il giorno che il letto
pieno di lei, stretto
sentì il cuore svanire
in un così lungo morire.
Guarda l’orologio: è fermo.
Vorrebbe domandare
al capotreno. Vorrebbe
sapere se deve aspettare
ancora molto. Ma come
come può, lei, sentire,
mentre le resta in gola
(c’è un fumo) la parola,
ch’è proprio negli occhi dei cani
la nebbia del suo domani?
(da Versi Livornesi ne Il seme del piangere, 1952-1958)